

 |
 |
I racconti e leggende che seguono, ove non sia riportata la fonte con indicazione dell'autore e dell'editore, sono tratte dalla tradizione orale, particolarmente cospicua e tuttora presente, anche se ovviamente ridimensionata, nel territorio dell'Amiata.
Il drago della Selva
Molti appartenenti alle passate generazioni, oggi cinquantenni o sessantenni, hanno avuto ancora la fortuna quand' erano bimbi, di sentirsi raccontare le favole e le novelle dei loro luoghi, tramandate da tradizioni secolari, ricche di fantasie e molte volte collegate a fatti realmente avvenuti, anche se ammantati dal sapore di leggenda.
Sull' Amiata, nelle lunghe sere d' inverno, accanto al camino scoppiettante, con vicino un piatto di castagne lessate, i citti ascoltavano con grande interesse e con grande curiosità ciò che raccontavano gli anziani. Un nonno, fra i più carichi di anni e di esperienze, raccontava la favola del drago di Santa Fiora (ovvero del "Cifero serpente", come dice la tradizione), soffermandosi ogni tanto a testimoniare gli aspetti più verosimili, sottolineando fatti storici realmente avvenuti che indubbiamente erano collegati alla favola e peraltro conosciuti come veri in tutti i paesi del monte Amiata.
I frati del convento
della Selva, vicino a Santa Fiora, si erano accorti da tempo
della presenza di un orrendo e gigantesco drago, che si era ormai
stabilito nei boschi fra Santa Fiora e la Selva, e faceva immensi
danni e misfatti. Non solo mangiava mucche, pecore ed altri
animali, ma la sua ferocia arrivava ad uccidere un uomo al
giorno, scegliendolo fra pastori, taglialegna e gli stessi
frati,che venivano così decimati.
La sua bocca, continuamente spalancata era come un lanciafiamme: fuoco e fumi densi uscivano da quelle fauci con una veemenza impressionante, tant'è che spesso si avevano grandi incendi di boschi.
A quei tempi erano padrone di Santa Fiora le famiglie Aldobrandeschi e Bosio Sforza. Da un matrimonio intervenuto fra principi di queste due famiglie, era nato il giovane conte Guido, molto amato dal popolo e destinato a governare a lungo il paese ed il contado. I frati chiesero aiuto a lui, che provò ad attrezzarsi con corazze, lance ed archibugi, cercando di sconfiggere da solo il drago. Ritornò sconvolto, si era salvato per miracolo dalla furia del drago. Disse che occorrevano validi rinforzi perchè il drago era pericoloso e feroce, e non poteva essere affrontato da uomini soli.
Si trattava quindi di organizzare una spedizione contro il drago, o cifero-serpente, che dirsivoglia. L' unico personaggio che avrebbe potuto dirigere una operazione del genere era il mago di Arcidosso, il famoso mago Merlino, che aveva preso dimora da tempo in una grotta sulla strada che da Arcidosso porta a S.Lorenzo. Questa grotta, pur parzialmente crollata e affogata da arbusti e vegetazione, esiste tuttora a riprova di una reale esistenza del mago.
Merlino univa ai suoi poteri di magia, anche una grande fama e considerazione di uomo saggio e potente (si dice che lui, mago e alchimista, facesse parte di una nobile famiglia fiorentina che mirava alla conquista della Signoria di Firenze, uscendone tuttavia sconfitta in modo cruento, ma conservando prestigio e beni). Non fu difficile per lui chiamare il cavalier Giorgio, il grande combattente cristiano, le cui imprese militari a favore della fede erano largamente conosciute.
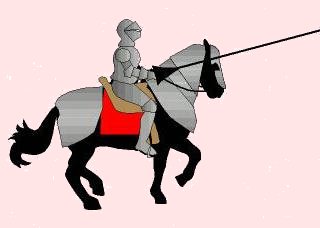 Chiamato quindi dal Mago Merlino, giunse
ad Arcidosso il cavalier Giorgio, che fu subito
ospitato dal conte Guido di Santa Fiora e dai frati del convento
della Selva. Organizzarono un piano per incastrare il malefico
drago, che era rintanato nella sua grande caverna, nel folto del
bosco. Alcuni giovani fraticelli tremanti si misero a ballare e a
cantare davanti all' ingresso della grotta, come esca perchè il
drago venisse fuori, dove avrebbe trovato la sorpresa che gli era
stata preparata. Il drago uscì imbestialito e fumante. Ma dall'
alto di un grande castagno, una scarica di frecce e di lance si
abbattè su di lui. Un colpo di lancia del cavalier Giorgio finì
per sempre quel mostro sanguinario, che tanto male aveva
procurato alla mite gente dell' Amiata. Nella sagrestia della chiesa
della Trinità, che fa parte del convento della Selva, i
frati fanno ancora vedere, a conferma della veridicità della
storia, una mascella mostruosa che era quella del drago.
Forse si tratta di una mascella di coccodrillo, trofeo di caccia
di qualche personaggio locale, ma forse non è il caso di
dissacrare una così suggestiva leggenda.
Chiamato quindi dal Mago Merlino, giunse
ad Arcidosso il cavalier Giorgio, che fu subito
ospitato dal conte Guido di Santa Fiora e dai frati del convento
della Selva. Organizzarono un piano per incastrare il malefico
drago, che era rintanato nella sua grande caverna, nel folto del
bosco. Alcuni giovani fraticelli tremanti si misero a ballare e a
cantare davanti all' ingresso della grotta, come esca perchè il
drago venisse fuori, dove avrebbe trovato la sorpresa che gli era
stata preparata. Il drago uscì imbestialito e fumante. Ma dall'
alto di un grande castagno, una scarica di frecce e di lance si
abbattè su di lui. Un colpo di lancia del cavalier Giorgio finì
per sempre quel mostro sanguinario, che tanto male aveva
procurato alla mite gente dell' Amiata. Nella sagrestia della chiesa
della Trinità, che fa parte del convento della Selva, i
frati fanno ancora vedere, a conferma della veridicità della
storia, una mascella mostruosa che era quella del drago.
Forse si tratta di una mascella di coccodrillo, trofeo di caccia
di qualche personaggio locale, ma forse non è il caso di
dissacrare una così suggestiva leggenda.
Il Cavalier Giorgio ammazzò altri orrendi e feroci draghi, divenne un santo, ed oggi è il santo patrono di Genova.
![]()
Il Prato dell'Amore
Nei freddi poderi di montagna, nelle sere d' inverno, al caldo delle stalle, i nonni trattenevano a veglia i componenti della famiglia, per raccontare loro una storia di grande suggestione umana, in cui il sentimento dell' amore si rivestiva di significati di gran dolcezza e tenerezza.
Il Prato della Contessa, un grande pianoro a 1400 metri di altitudine sulle falde del monte Amiata, circondato da maestose faggete e da abetaie che profumano resina, deve il suo nome ad un episodio d' amore che vide protagonisti la contessina Gherarda degli Aldobrandeschi di Santa Fiora e il giovane Adelardo, feudatario di Chiusi, che molto spesso si dedicava a tornei d' arme e a competizioni cavalleresche. In una di queste, svoltasi a Buonconvento, Gherarda lo conobbe e ne rimase colpita.
Siccome Gherarda era una giovane tutta pepe, che non si rassegnava facilmente, fece di tutto per far organizzare ai monaci dell' Abbazia cistercense di S.Salvatore, presso cui trascorreva alcuni mesi dell' anno per studio ma anche per rafforzare i favorevoli rapporti che in quel momento erano in atto fra la sua potente casata e l' altrettanto potente Abbazia, un torneo equestre con il secondo fine di rivedere Adelardo, signorotto di Chiusi.
 Fu scelto dai monaci un territorio
pianeggiante, l' unico possibile, quello del Prato che poi fu
detto della Contessa, dove allora (si era in pieno medioevo)
furono abbattute piante secolari per far spazio al carosello.
Così Gherarda e Adelardo si rividero ed amoreggiarono spesso
proprio in quel luogo, che rappresentava la cornice ideale ad un
grande, piccolo amore di giovani adolescenti.
Fu scelto dai monaci un territorio
pianeggiante, l' unico possibile, quello del Prato che poi fu
detto della Contessa, dove allora (si era in pieno medioevo)
furono abbattute piante secolari per far spazio al carosello.
Così Gherarda e Adelardo si rividero ed amoreggiarono spesso
proprio in quel luogo, che rappresentava la cornice ideale ad un
grande, piccolo amore di giovani adolescenti.
Poi la storia non ebbe il seguito che ognuno si potrebbe aspettare. Gherarda andò sposa ad un rampollo degli Orsini di Pitigliano perchè così era stato deciso, per convenienze politiche, dalle due illustri famiglie. Un matrimonio combinato, che ebbe come conseguenza l' apertura delle porte di un convento per il giovane Adelardo, e di lui non si seppe più nulla.
E' rimasto quel Prato, nato per amore, cui furono poi attribuiti fatti dolci e suggestivi, forsanche per l' amenità del posto e per il mistico aspetto della natura che lo circondava.
Si disse che nel lontano quattrocento, le più belle ragazze delle comunità di Arcidosso e di Casteldelpiano si sentivano irresistibilmente attratte da una forza sublime e misteriosa che le faceva salire verso la montagna. Si fermavano al Prato della Contessa, ove si incontravano con gli Angeli, che scendevano per loro dal cielo nelle sere tiepide d' estate.
Da quegli amori nascevano bimbi bellissimi, che si chiamavano Cherubino, Serafino, Michele, Gabriele e così via, nomi che poi sono diventati comuni in quell' epoca lontana fra la gente dell' Amiata.
Da qui anche la tradizione secolare, presente fino a qualche decennio fa, di vestire i bambini da angioletti, con tanto di ali variopinte, e di farli sfilare a cavallo nelle processioni religiose, ad evocare quei miracolosi eventi che si consumarono al Prato della Contessa, il prato dell' Amore.
![]()
La montagna incantata
Venendo da Santa Fiora, oltrepassati Marroneto e Bagnolo, c'è una strada che porta proprio in cima al monte Amiata ed è così piena di suggestioni che, una volta che la conosci, ci torni per farla ancora, anche se non devi salire alla Vetta. A un tratto la strada solca una grande e morbida collina vestita di abeti. Sono alti, diritti, allineati a distanze regolari. E' improbabile trovarne due vicini tra loro molto più di quanto lo siano gli altri, o un tratto dove non ne siano infissi la quantità prescritta.
Ma non è opera dell'uomo, che non saprebbe disporli così ordinati perchè, se provasse a farlo, loro non gli darebbero retta. Alcuni non attecchirebbero, altri verrebbero uccisi dalla supremazia di quelli accanto. In seguito, coi decenni, la natura giungerebbe a darsi l'ordine suo, come ha fatto su quella collina e come fa sempre, con metodo testardo e immutabile.
Prosperano soltanto dove e quando c'è lo spazio giusto: se ce n'è poco il più gracile, cioè quello con la posizione iniziale più sfavorevole, deperisce finchè soccombe, lasciando il dovuto ambito vitale agli altri: Se ce n'è in abbondanza uno nuovo fluisce dalla terra attraverso un seme, caduto insieme a tanti altri, eppure il solo destinato dal caso a una procreazione fertile.
Quando uno degli abeti, già adulto, muore per il fulmine o schiantato dal peso della neve o perchè ha concluso il suo ciclo, ecco che un insolito brano di cielo si apre, una quantità inconsueta di rugiada giunge al suolo, una razione di nutrimento della terra è d'avanzo. Così un germoglio s'affretta a salire verso quell'insperato dono di luce e la sua stenta vita tripudia improvvisa. Per anni lo puoi vedere andar su così sottile e diritto, preciso e senza scarti che ti pare scivoli ubbidiente lungo una guida precostituita. Per anni si nutre soltanto del sole di mezzogiorno, perchè quello inclinato del mattino e della sera non gli tocca. Per anni la pioggia, specie se cade a vento, lo bagna dopo aver lavato gli altri ed esso non può sentirsi allacciato alla nubi dalla gremita imbastitura delle gocce. Eppure, ostinato, s'incaponisce a salire, a salire finchè, col favore di un'ultima primavera, eccolo là, a guardare alla pari con gli altri un panorama di cima verdi. E s'è già scordato di quando aveva intorno e addosso solo un'oppressiva legione di tronchi ruvidi e marroni, ma non insuperbisce e non progetta predomini che non ci potranno essere, perchè non ci sono mai stati.
Di storie così, in un bosco come quello, ne iniziano e se ne concludono di continuo, ma sempre a discrezione della natura, non con i ritmi chiesti dall'uomo ed è solo per questo, grazie a questo, che un bosco così si veste di fascino.
| Ci sono più stagioni per poterselo godere e più ore del giorno per ammirarlo. D'inverno con la neve, ogni fusto è come un cero infisso nella sua torciera allargata dalle colature, mentre i rami, ingoffiti dal viluppo candido, pendono sfiniti. Ogni tanto una di queste matasse gelide scivola, cade ai piani sottostanti e libera anche quelli dal loro fardello, in uno sfarinio luccicante. Allora vedi le frasche, ingobbite e scarmigliate, dare una frustata, scrollarsi come fa un cane infradiciato e piano piano riprendere l'ordine spettante. Gli aghi verdi si allineano compiti riformando le giuste strutture e i rami riprendono la posizione loro, a formare col tronco l'angolo consueto. C'è un silenzio che non pare terreno, solo tu lo puoi snaturare, ma già ti pare una mancanza di rispetto lo scricchiolio della neve sotto gli stivali, parlare sarebbe un sacrilegio e, se c'è bisogno, lo fai sottovoce. Non ci sono voli nè gridi, gli uccelli per lo più sono scesi verso il piano, mentre gli altri animali della montagna o dormono infagottati nelle loro riserve di grasso sotto qualche radice o stanno, nascosti e sconsolati, ad aspettare che il peggio passi. Quelli che si azzardano fuori lo fanno circospetti e silenziosi e non aggiungono parvenze di vita allo scenario. |
Nelle altre stagioni il momento più bello è l'alba, o almeno l'ora del primo sole: esso prova radente a sgattaiolare tra un tronco e un altro, ma non giunge a poterti guardare negli occhi. Sbatte, rimbalza, si frantuma, trova un varco, incespica e si disperde ancora finchè, disarticolato e tenue, resta a pulsare a mezz'aria. Il suo balenio risulta domato dalla solenne trama del bosco, eppure, anche se incipriato dai velami che fumigano al suo tepore, è lì, sai che c'è e ti dici: tra un momento vince. E aspetti curioso che lo faccia, per vedere dove cadrà la prima stilettata di luce viva.
Se poi per la strada tortuosa della Vetta continui a salire, il fondale muta: i grandi faggi contorti e colorati invadono il proscenio e gli spazi si dilatano. Pietre parlanti dicono di quando furono sputate dal vulcano in ere trascorse, di come furono sfaccettate e incavate dai secoli e di cosa oggi tentano di apparire: una torre, un volto o il profilo grifagno d'un falco.
Certo, ci vuole un pò di benevola ispirazione, ma, a possederla, puoi anche andare oltre e trovarti, una sera verso il tramonto, a incontrare tra le felci alte un essere snello e danzante che, mentre trabalza rapido dietro un cespuglio, si lascia vedere per un istante con la barbetta, con quelle piccole corna appuntite, quei piedi caprini sotto ai ginocchi ossuti e il flauto tra le mani.
E se ti accade, nel più folto del bosco, di imbatterti in una capanna disabitata e lì accanto di scoprire due vecchie piante, l'una accosto all'altra, che pare si tengano per mano, è soltanto perchè non sono una quercia e un tiglio che non ti convinci d'aver incontrato Filemone e Bauci.
E' a guardarla con questi occhi che ci si innamora della mia montagna e anche qui, come per il turgore dei suoi orti, mi faccio scrupolo a scommettere che sia la più bella solo per non sembrare un provinciale campanilista.
(tratta da "Lo zufolo di canna" di Franco Lazzarini, edizioni Cassero del Sale, Grosseto, 1993)
![]()
Cavalcature
Cencio, Gigi, Nanni e Berto si alzano presto, due ore prima del sole, per zappare un po' di più pel fresco. Caricano nell'asino due corbelli, uno pieno di concime, l'altro co' due barlette d'acqua, quattro ubbidienti, quattro paia di zocculi, quattro paia di carzonacci, mezzo paniere di fette di pulenda, un pò di pane e poco companatico. Si danno da fa', la terra è dura, è un mese che non piove. Una veloce colazione verso l'otto, a mezzogiorno dopo mangiato tentano di fare un riposino, ma è impossibile: le codere, se ti sdrai in terra ti mangiano, le cicale ti rincoglioniscono.
"Riandiamo a zappa' n'antro poco, vor dì che in serata partiremo un pochino prima. Sull'asino ci monteremo un pochino per uno"
 |
Verso le sei i quattro fratelli partono. "Ci monterò prima io" disse Cencio. "su pe' cheste piagge ci si sta anche maluccio sull'asino....Ci starò fino al bivio di Montegiovi". "Vor dì che io ci salirò da bivio di Montegiovi al ponte della Pieve" disse Gigi, "tanto è tutto per in giù 'sto tratto di via". "Allora io ci monterò da ponte della Pieve al paese" disse Nanni, "è il pezzetto più corto..." "E a me quando mi tocca?" protestò Berto. "A te ti tocca nella stalla, intanto che mamma finisce di coce la pasta". |
(tratta da "Diario d'Amiata" di Alvaro Giannelli, edizioni Liberetà, Roma, 1998)
![]()
La fiera di Casteldelpiano
Era normale non andare a scuola la mattina del venti gennaio, il giorno della grande fiera del mercatone di San Bastiano. Ricordo quella del 1940.
Anch'io quella mattina non andai a scuola, però di buon ora mi recai prima in chiesa dal Proposto, ch'era mio zio don Natale Gallorini, per servire due messe. Una con don Romolo Romboli, parroco di Roccalbegna, la seconda con don Francesco Pellegrini, parroco di Cinigiano, cioli tutti e due. La mancia che mi dettero fu di una lira ciascuno, così mi trovai con due lire in tasca e partii per la fiera. Incontrai subito in piazza i miei amici Felice Moroni ed Ennio Mearini, con cui si frequentava la stessa scuola. Era costume di iniziare da fondo al borgo.
C'erano i banchi della pannina, tagli di stoffa lunghi, di colore grigio e marrone, chiari e scuri, neri e blu. I venditori facevano salire su uno sgabello a scale chi voleva acquistare e gli mettevano il taglio sulla spalla: facevano divenire giganti anche uomini molto piccini, facendo scendere la stoffa due scalini sotto i piedi. Poi chiamavano la gente e chiedevano: "Come vi pare? E' più bello?". E tutti ne convenivano.
Quindi si veniva davanti al Bardelli, dove c'era il banco-barroccio di Pietrino Chei, detto anche il Fusaino, che veniva da Badia Prataglia di Arezzo. Dopo due giorni di viaggio con barroccio e due cavalli arrivava la sera tardi al podere del Colombaio, dove stava il mi' zio Poldo, e qui veniva ospitato. Il barroccio era pieno degli oggetti di legno costruiti da Pietrino e dalla sua famiglia: fusi per filare, sete e setini per setacciare la farina, palette e taglieri, mesculini, passatoie e preti per mettere lo scaldino a letto.
Quando noi ragazzini si fu davanti al barroccio, ci si fermò. Pietrino era furbo e trattava con una donna la vendita di un prete. Chiedeva sei lire, la bella mora gliene voleva dare cinque. Ma Pietrino fu irremovibile: "Te meno di sei lire il me' prete non ce ne porti a letto. Anche se so che qualche altro prete pe' venì nello stesso letto te ne darebbe dieci e anco quindici".
Andando più su, davanti alla farmacia, c'era il banco dei chicchi. A venderli erano due anziani di Arcidosso, ciarpa nera con frange lunghe lei, occhialoni spessi lui. Poche caraffe sopra un tavolino nero, con dentro i sigarini di tutti i colori, come l'arcobaleno, e il sugarorizio (bastoncino di liquerizia). Noi si comprò il sugarorizio, perchè faceva venire la bocca nera e perchè durava di più.
Più in là, davanti all'edicola, dove allora c'erano i pisciatoi, c'era il grande banco del Baietto, tutto di ferramenta, arnesi agricoli e per boscaioli, falci, zappe, picchette, pale, pennati, farcini... Baietto portava un cappellone nero con falde grandi e un fiocco nero. In quel momento, mentre si passava noi, Baietto fece cadere una falce fienaia sopra la massicciata della strada (allora solo imbrecciata) per dimostrare ai clienti che era di acciaio puro. Il contadino che voleva comprare la falce era vestito di velluto, con un cappellaccio in capo, era grosso e basso e a noi non ci garbava. Baietto gli chiese quindici lire, il contadino ne offrì otto. Baietto lo guardò dall'alto in basso e gli disse:"E ti 'eggo bello e vestito bene, gira e vai".
Si andò ancora avanti, e davati a Iadere fotografo c'era un cantastorie con la fisarmonica, che cantava una storia triste e dolorosa: quella di un contadino che aveva ammazzato un ragazzino di undici anni per avergli rubato quattro pere.
Noi avevamo undici anni, e una volta d'estate nel campicinchio dell'ingegnere Giannelli di pere se ne rubò almeno venti. La paura ci prese davvero quando si avvicinò al cantastorie una donna vecchia e grossa, la pora Brocia della Casella Alta, con un fazzoletto grande in mano, gli cascavano i lucciconi a venti metri prima di arrivare, piangendo: "Poro cittino, 'sta creatura, 'sto delinquente l'ha ammazzato".
Dall'angolo del piazzone si vide poi un branco di uomini, quasi tutti vecchi, ammucchiati dietro al monumento del capitano Santucci. Io e i miei compagni si andò subito a vedere che facevano raggruppati dietro le piante di alloro della piazzetta (furono seccate dal gelo del febbraio 1956, i cedri attuali sono stati piantati nel 1957). Erano tutti intorno a un uomo che li invitava uno alla volta a sedere su una sedia con una spalliera alta come una poltrona. Si vide che gli cavava un dente a ciascuno, si udì che qualcuno berciava. Dopo la cavatura, il cliente andava nell'ultimo pinzo del giardinetto a sputare, ripulendosi un pò con il fazzoletto, poi aspettava. Quando erano due o tre clienti, andavano col dentista dal Capone, a bere un cognacchino che serviva anche da sciacquo. Dopodichè il dentista ritornava al suo lavoro. Lo chiamavano chi Leoni, chi Meco, chi dentista. Con la sua pinza sanguinante in mano, svolgeva il suo lavoro alle fiere. I suoi clienti erano i contadini e la gente del paese che, approfittando della fiera, si faceva levare i denti bacati più grossi, dando al dentista poche lire. Io e i miei compagni eravamo impauriti, schifati, ma eravamo bloccati lì per la curiosità.
Poi ci si avviò verso il Piazzone; ai vecchi olmi che lo circondavano (tagliati nel 1951) erano legati tanti asini e qualche cavallo. Nel mezzo del Piazzone, allora campo sportivo e di calcio, con le porte murate, c'era qualche centinaio di vitelli, di bovi maremmani e chianini.
Davanti al consorzio agrario, fra tanta gente che guardava, c'erano quelli del gioco "cartina vince, cartina perde" e di quello del chicco di pepe nascosto sotto uno dei tre campanellini. In realtà il chicco di pepe restava sempre attaccato dietro il mignolo del prestigiatore, ma le vittime di questo imbroglio erano tante. Noi si pensava che fossero locchi.
Poi si assistette alla vendita di un asino da parte di un asinaio di Seggiano, il babbo di Boccabella, un ragazzo della nostra età. Prima ci fu la prova della corsa lungo il viale del consorzio, per vedre se l'asino era spallato. Poi gli si guardò in bocca per accertare l'età.
Dal Piazzone alla piazza dei maiali, l'attuale parco dei ragazzi. Era uno spiazzo brullo, c'erano costruiti due muri, il primo alto due metri arrotondato alla fine, l'altro alto tre e pieno di spigoli. Il maialino il 20 gennaio lo compravano solo le famiglie di piccoli proprietari che avevano il mangime per portarlo avanti. Le famiglie più povere lo compravano dopo Pasqua, alla fiera di San Vincenzo. La mattina della grande fiera c'erano tante ceste di legno intrecciato. Nella mattinata avevano contenuto ognuna otto o nove maialini tutti fratelli, ma siccome venivano venduti per primi sempre i meglio, quando erano rimasti tre o quattro animali per ogni cesta, i loro ospiti non erano nemmeno cugini.
Nella piazza dei
maiali si sentì sona' il mezzogiorno, così si corse tutti a
casa a mangiare. Verso l'una ci ritrovammo sotto la porta
dell'Orologio. La mattina si era comprato il sugarorizio, nel
pomeriggio si comprò i lupini da Giangio, che era il babbo di
Amata dell'albergo Manfredi. 
Giangio vendeva i lupini, i semi, le nocciole, le purnelle secche. Aveva una paniera a quattropiani e si metteva a vendere all'angolo del Rombuli sotto la porta dell'Orologio. Su ogni piano del paniere teneva tutto quel ben di Dio, ma noi ci si contentava di un bicchiere di lupini da dieci centesimi. I bicchieri parevano grandi, ma erano di culo grosso.
Poi si andò a vedere l'anguilla. La vendeva una donna di Piancastagnaio dietro l'angolo di Telemaco, tenendola dentro un bigonzo di legno rettangolare. Noi si guardava come ora si guarda un acquario. Una volta un vitello, durante la fiera, non so come scaricò dentro quel bigonzo. La donna, che si chiamava Beppa, non buttò l'anguilla, ma la ripulì bene, e poi, coprendola con un tovagliolo bello e bianco, la rigirò gridando a squarciagola: "Marinataaa!".
Continuando si trovava intorno all'obelisco di piazza Garibaldi, Crementa, detta la Gobba del Nicale, che vendeva stringhe, corregggioli di cane, triccioli per le mutande lunghe ed elastici per reggersi le calze, in un paniere ovale.
Ma già si stava facendo tardi e bisognava agginarsi. Allora si andò a fa' due tiri alla carabina del Padellina sotto la torre del Proposto. Ma c'era una folla di contadini avanti, e a noi non toccava mai.
Appena abbrucciò, ci fu il rientro di centinaia di persone. Tanti erano briachi, cantavano e si accompagnavano a vicenda, scappando dalle botteghe di vino e dalle frasche. Questa gente si vedeva di rado, erano contadini che venivano dalla campagna dei comuni vicini, si incontravano con i braccianti che a giugno sarebbero andati a segare il grano nei loro poderi. Erano uomini, che tra un bicchiere e l'altro, durante la giornata di fiera, si erano raccontati i loro drammi, i loro impegni, le loro passioni, i loro ricordi di gente che lavorava tanto e godeva poco.
Prima di anda' a casa si ritornò a vede' se il dentista c'era sempre. Aveva smesso di lavorare ed era vicino al bar del Capone quando gli domandarono: "Leoni, com'è andata oggi?". Lui stese un fazzoletto su un tavolino all'aperto e si mise a contare i denti cavandoli dalla giubba di velluto alla cacciatora. Alla fine del conto disse: "Questi so' ventidue, poi quattro non so' voluti venì e tre ci avevavo il frenulo: gli ho detto di rivenì a quest'altro mercato".
(tratta da "Diario d'Amiata", di Alvaro Giannelli, edizioni Liberetà, Roma, 1998)
![]()
La giuncata
La solennità dell'Ascensione, a Castellazzara, è la festa del latte. Si beve il latte crudo o bollito come un voto, una benedizione come per Pasqua l'uovo benedetto. Alla festa dell'Ascensione è legata la tradizione della giuncata. Cos'è la giuncata?
E' costituita da latte cagliato (rappreso, coagulato) che in tale stato si pone in un cestello di giunchi tessuti a mano (da cui il nome di giuncata) dal quale si lascia sgocciolare il siero: Rimane nel cestello il futuro costituente del formaggio e della ricotta.
Da ragazzo imparai, per curiosità, a tessere questi cestelli rustici con giunchi o con ginestra, che venivano usati per contenere la ricotta e non di rado venivano venduti all'acquirente con il prodotto. Talvolta la tessitura di giunco veniva sostituita da vimini e si formava una scodellina a forma di tronco di cono che in loco si chiamava "fuscella", forse perchè intessuta con fuscelli. Serviva per far sgocciolare la scotta e vendere la ricotta scolata. In tal caso la fuscella non veniva ceduta con la ricotta, ma si conservava per il successivo uso. Ma torniamo alla giuncata.
"Tista, Tista, alzati; è giorno e devi andare a fare la giuncata. Dante ti aspetta". E' la voce della mamma che mi sollecita perchè debbo partire per la campagna a domandar la giuncata. E' il giorno dell'Ascensione, quaranta giorni dopo Pasqua e l'aria nella montagna amiatina sembra mite. Però appena uscito di casa t'investe una brezza fresca che ti invita a camminare svelto per riscaldarti. Siamo pur sempre ad 815 metri sul mare ed ancora fa frescolino, specialmente di mattina.
Dante attende in cucina, fornito di un candido tovagliolo di bucato. Già di un tovagliolo, perchè alla vecchia e superata panierina di giunco, piuttosto fragile e non sempre del tutto pulita, si è sostituito un candido tovagliolo, talvolta di quelli tessuti nei telai rustici del paese. Il siero defluisce lo stesso, anche se un pò più lentamente che del cestello di giunco.
Con Dante ci avviamo per la strada della fonte, bianca e polverosa, con qualche pietra sporgente dal selciato. Per istrada troviamo altri ragazzi che si recano a "fare la giuncata" e insieme ci accingiamo a percorrere quattro chilometri di strada. Sorpassiamo il cimitero, il Bernarduccio, la valle cupa del Rigo e il ponte rosso. Superata la lieve salita dell'Ascina siamo prossimi all'arrivo e sulla destra si vede il casale il cui proprietario ci farà omaggio della giuncata.
Intanto le pecore, ancora sonnolente, stazzano chiuse nella rete ed attendono che sia asciugata la guazza per essere condotte al pascolo.
La passeggiata piuttosto insolita effettuata di buon mattino e la temperatura fresca di questo clima montano, ci mettono appetito ed allora dalle capaci e gonfie tasche escono pezzi di pane con formaggio, un uovo sodo e una fetta di salsicciotto, che vengono consumati presso un fontanile. E' anche un modo per ingannare l'attesa.
Finalmente il pastore, munito del rituale secchio si dirige allo stazzo per effettuare la mungitura. Siamo prossimi a ritirare la giuncata.
Qualcuno va a curiosare nel podere per vedere come si fa la giuncata. Io, che nella casa del nonno avevo veduto cagliare il latte centinaia di volte, non vado ed attendo chiacchierando con gli altri ragazzi.
|
Il latte, tiepido e spumoso, viene colato con un telo di bucato in modo che le eventuali impurità rimangano nel telo, e nella caldaia stagnata scende il latte puro. La caldaia si pone sul fuoco a fiamma viva, ma non molto ardente, in modo da portare la temperatura del latte a circa 37 gradi, cioè alla temperatura umana. La temperatura si misura immettendo un dito nel latte ed il casaro si regola in tal modo. Il casaro scioglie nel latte tiepido una piccola quantità di caglio, ottenuto dal quarto stomaco degli agnelli macellati, e lo pone nella caldaia. Con la chiova rimuove il latte in modo che il caglio si diffonda uniformemente su tutta la massa, poi pone la chiova di traverso alla caldaia e, non senza prima aver tracciato un simbolico cenno di croce sul latte, copre con un panno e attende un pò di tempo. |
 |
Dopo alcuni minuti, con il dorso della mano, saggia la consistenza della cagliata, e quando gli par giusta, inizia la distribuzione.
Tutti saliamo alla casa poderale e tutti siamo pronti con il nostro tovagliolo di bucato a ricevere la nostra porzione di latte rappreso. Con un mestolo forato è iniziata la distribuzione del latte cagliato, mentre i tovaglioli sono tenuti con le mani per le quattro cocche in modo da formare una specie di cestello. Il tovagliolo, ricevuto il latte, viene legato con doppio nodo per le cocche opposte e comincia lo sgocciolio del siero. Le quattro cocche legate offrono una buona presa per la mano che si pone distante dai pantaloni perchè il siero non sgoccioli sugli abiti bagnandoli e sporcandoli.
Spesso i ragazzi si forniscono di una lunga pertica, vi infilano le giuncate ed a turno, in due, portano il carico. Cinquanta anni fa era difficile incontrare veicoli sulla strada del ritorno. Il ritorno a casa è piuttosto rapido in quanto la giuncata si deve consumare per la prima colazione o per il pranzo. Il latte cagliato, sgocciolato del siero, con su le impronte della tela (o dei giunchi se si era usato un cestello), viene posto in un piatto e suddiviso in tante parti quante sono le persone della famiglia. Si invoca la benedizione del Signore e finalmente si consuma la giuncata.
(di Gio Battista Ruffaldi. Tratta da "Castellazzara e il suo territorio", di G.Battista Vicarelli, edizioni Cantagalli, Siena)
![]()
Il maiale-day
Il lamento stridulo di un maiale che
veniva ammazzato echeggiava per il paese mezzo addormentato nel freddo gelido
di una mattina di dicembre. Dalla durata del lamento si capiva se il norcino aveva messo lo spiraglio al punto giusto.
Ammazzare il maiale era allora come una
festa. La conclusione di un ciclo di lavoro paziente, che aveva avuto inizio
il giorno della fiera, dove un mercante di Abbadia portava maialini vivaci e chiassosi. Il capoccia sceglieva tra tanti
maialetti in mostra quello che aveva la schiena più lunga. Doveva essere di
buona razza, possibilmente un lattonzolo di cinta senese. Nè troppo grosso nè gallustro. L'arello era già stato pulito e
impagliato."Sant'Antonio lo protegga"
diceva il capoccia. "San Martino l'accresca",
rispondeva la massaia. "Dio lo faccia" concludevano
in coro.
Il compito del capoccia era finito. Il
porchetto apparteneva ora alla massaia che doveva farne un maiale grosso e
saporito.
La vita del maiale scorreva tranquilla e
in perfetta armonia con quella della famiglia.
Con l'acqua dove aveva cotto la pasta la
massaia dava una sgrossata ai piatti. Vi aggiungeva poi semola orzo e bucce
di patate e la scotta se c'era. Un pò di ghianda raccattata dai ragazzi nei
boschi, un po' di castagne marcite completavano il menù. Un giorno arrivava il castrino e tutti i
maiali del paese venivano castrati.
Quando cominciavano i primi freddi, tra
una bevuta e l'altra, gli uomini discutevano all'osteria la data dell'ammazzatura. Per Tonio la fine di dicembre era il
periodo migliore perchè così, diceva, per le feste hai qualcosa di buono da
mettere sotto
i denti.
Per Beppe invece era meglio aspettare la
metà di gennaio. " Fa più freddo e la tramontana asciuga
meglio la carne."La verità era che voleva finire la
ghianda e quel mucchio di patate mezze marce, se no gli toccava buttarle, chè
senz'altro non ci arrivano all'anno dopo. Discutevano e bevevano e nessuno si
decideva a prendere l'iniziativa.
Poi un giorno passava il norcino e tutti
ammazzavano il maiale. Perchè al paese erano così. Nessuno
voleva essere il primo, ma neppure l'ultimo. Ed allora tutti facevano le
stesse cose nello stesso momento, creando in tutto il paese una strana
animazione che sapeva di festa.
Tutto il giorno sentivi nell'aria
le strida acute del maiale e tutti correvano qua e là affaccendati. Il capoccia andava a prendere il maiale
all'arello e attirandolo con qualche vago di granturco, piano piano, per non
fargli arrossare la carne, lo conduceva nello spiazzo davanti casa.
Lì ad aspettarlo, c'erano il norcino e
gli amici venuti a dargli una
mano. Il maiale, preso per le zampe e per la coda,veniva atterrato. Il
norcino affondava il ferro acuminato nella carne, proprio in direzione del
cuore. Poi estraeva lo spiraglio ed tappava la ferita con lo zeppetto che
teneva pronto tra i denti.
La massaia intanto aveva acceso il fuoco
e attaccato alle catene due
paioli colmi d'acqua. Gli uomini preparavano la cupella sulla porta di casa. I
pignatti di acqua bollente passavano di mano in mano e gli uomini, con i
coltelli ben affilati, raschiavano la pelle scottata del maiale.
Fra nubi di vapore, chiacchiere e vino
finiva la pelatura. Ognuno vantava il suo maiale perchè era
più grosso e meno grasso degli altri. I commenti continuavano poi all'osteria
e finivano in discussione. E magari anche a botte se qualcuno beveva un
bicchiere di troppo.
Con un rudimentale sistema ad argano e
birello, il maiale veniva sollevato poi per le zampe posteriori fintanto che,
tra il grugno e il pavimento ci fosse spazio sufficiente per mettere un
catino. Il norcino affilava il coltello.
Incideva la carne al centro dei due cosci posteriori e giù, dritto sul ventre
fino all'ombellico.
A questo punto il solito pivello
veniva mandato con qualche scusa dietro la schiena del maiale. Tra le
risate di tutti avrebbe finito col prendersi in testa un colpo di piciale.
La Peppa,
col capisteio in testa tenuto fermo da una coroglia, andava
al fosso a strigare e a lavare i budelli di tutti i maiali del paese. Si
accontentava in cambio di poche lire o di un piatto di polenta.
Il norcino preparava fegato, grasselli e
strigoli, qualche pezzetto di coratella e qua e là , senza sciupare la
bestia, rifilava qualche pezzetto di magro. Nella stanza si diffondeva un gradevole
profumo di finocchio. Gli uomini intanto preparavano i legni per tenere ben
largo il ventre e il torace del maiale.
La massaia staccava il paiolo dalla
catena e lo portava fuori dall'uscio perchè la polenta si raffreddasse un
poco prima di versarla sulla spianatoia. Qualcuno attirato dall'odore dei
fegatelli appariva all'uscio. "Venite, venite!
Ce n'è per tutti" diceva il capoccia, facendosi incontro
all'ospite.
Dopo un paio di giorni si procedeva alla
spezzatura.
Sotto le mani sapienti del norcino piano
piano il maiale cedeva il posto a prosciutti, salciccia, ventresca e
soppressata, buristo e mazzafegati. Ora toccava a lui sfamare la famiglia che
tanto amorevolmente lo aveva allevato.
Mi ricordo che il poro Sabatino, quando
ammazzavano il suo maiale, spariva dalla circolazione. I maligni dicevano che
era uno scansafatiche. Ma Sabatino,
dietro il suo carattere
rude nascondeva un'anima romantica. Non sopportava vedere ammazzare il suo
maiale.
Quell'animale gli aveva fatto compagnia
per un intero anno e lui ci si era affezionato.
(Racconto di Carla Vannetti)
Il segreto di famiglia
Tonino
era sceso col suo carro di bovi dal podere di Montecaprilli giù fino all'Orcia,
al molino dell'Abbocco, per macinare. Doveva esserci stata molta altra gente,
perchè Tonino aveva fatto tardi e si era rimesso in strada che saranno state
l'una di notte; si dice, infatti, che chi prima arriva, prima macina e ora la
notte era fonda e la campagna silenziosa. Ma Tonino era contento perchè aveva
lavorato bene e conosceva a menadito la strada che lo avrebbe ricondotto a
casa.
Ma
improvvisamente, davanti a lui, qualcosa che lo lascia stupito e poi
inorridito: è un'ombra nera che cammina sulla proda e che lui
riconosce di colpo, anche se di spalle e infagottata: quella del fratello
morto in guerra tanti anni prima. Tonino ha vogli a di fermarsi o di scappare,
ma il terrore lo immobilizza sul suo carretto che continua a sobbalzare lento
sulla strada. Anche l'ombra continua a camminare, come se non sentisse il
rumore o non indovinasse chi sopraggiunge nel cuore della notte: procede allo
stesso passo dei bovi, mantenendo la stessa distanza. Tonino trema e cerca una
via di scampo, ma il podere, il molino e il paese sono lontani e non c'è che
buio e silenzio in quella notte. Poi pensa che tra poco, al Crocino, la strada
si biforcherà e gli sarà possibile imboccare una via diversa da quella della
sua imbrazzante guida. Così succede infatti: l'ombra volta da una
parte e Tonino scivola subito via per l'altra col suo carretto. Ora non pensa
di arrivare al podere, per spiegarsi e dimenticare quella terribile avventura:
sprona le bestie perchè vadano più veloci ed arriva alla strada che dalla
stazione di Monte Amiata porta a Castelnuovo dell'Abate. Anche la via
imboccata dall'ombra porta a quella strada, ma più a valle, e - anche
nel caso volesse continuare a perseguitarlo - Tonino conta sul suo vantaggio.
"L'avrò sperso..." pensa.
Tonino è inorridito, non sa che pensare, non sa che fare, vi
potete immaginare la sudarella che gli venne per tutto quel tragitto. La sua
unica speranza riposava ora nel paese e nelle case di Bassomondo, che doveva
attraversare. Ci arriva col cuore in gola e col proposito di chiamare forte
Babbone e di chiedergli il piacere di aprirgli la stalla per rimettere
le bestie e di ospitarlo per quella notte.
Ma
quando fu arrivato non ebbe il fiato per chiamare e rimane agghiacciato sul
carro, mentre i bovi lo conducono ancora avanti, verso il podere. Il viaggio
continua, ma quando l'ombra arriva a quei due quercioni che crescono sotto
Montecaprilli, si ferma, aspetta il carretto, e a Tonino che passa inorridito,
lo spettro del fratello muove le labbra e parla:"E' così che hai
mantenuto la promessa che m'hai fatto ?"
Non
si sa altro: il segreto della famiglia e del paese ha censurato l'accusa del
fantasma ed anche la storia è trapelata a stento, filtrata attraverso la
paura e la partecipazione di tutta la comunità.
Di
Tonino si sa che quella notte si mise subito a letto con una febbre che
"non la poteva", e il dottore che fu chiamato "non la trovava
nel termometro perchè guardava in mezzo e invece era in cima". Questo
febbrone gli rimase per un po', poi passò e Tonino divenne un sant'uomo. Da
allora in poi non perse una messa!
Il
fatto successe a Castelnuovo dell'Abate prima del 1930. Una donna, qualche
tempo dopo, chiese alla moglie di Tonino se fosse accaduto veramente. E
quella: "Sapete....so' quelle notti...". La storia infatti era
accaduta il 2 novembre, la notte dei morti.
(tratta
da "Qualcosa di bianco in Maremma" di Roberto Ferretti e Pier G.
Zotti, edizioni Amm.ne Provinciale di Grosseto) Angelica Era una di quelle serate invernali che rendono buia l'atmosfera
fin dal primo pomeriggio e fanno della notte la parte enormemente più lunga
della giornata. Zelindo, dopo aver trangugiato un pasto frugale, indossa il
vestito buono (il meno lacero), tenuto sotto naftalina nell'armadio e si avvia
verso il teatro degli Unanimi, trasformato per quell'ultimo giorno di carnevale
in salone da ballo per ospitare le coppiette e le maschere in uno dei rari
momenti di incontro e di festa che si potevano presentare in quei tempi lontani,
a quantificarli circa un secolo e mezzo fa. Zelindo, vent'anni o forse più, percorre la strada a piedi. Fa
freddo ed il cielo è minaccioso, ma non nevica e neppure piove. Mentre sta per
iniziare la salita che introduce alle prime case del paese, intravede una
fanciulla di bianco vestita, dietro un angolo di muro, forse nell'atto di
aspettare qualcuno. E' bella, sorride leggermente intimorita dalla presenza
maschile. Zelindo prende coraggio e, senza pensare ad altro, la invita
al veglione di carnevale, pensando che forse anche lei è diretta lì. La
fanciulla accetta timidamente l'invito e si incamminano insieme verso il luogo
del veglione. Fu una serata festosa che per Zelindo rimase memorabile. Nella
sala i giovani erano allegri e gioiosi, la compagnia non mancava, ma la
fanciulla vestita di bianco ballò tutta la sera con lui. Angelica si chiamava,
era dolce, serena, anche se nei suoi occhi apparivano lampi di mestizia. Lui le
chiese dove abitasse, con la segreta speranza di poterla ritrovare qualche
giorno dopo. Gli disse che abitava con i vecchi genitori in via delle Volpi al
portone numero 3. Nella sala, riscaldata solo dalle numerose presenze dei giovani
e dal movimento vorticoso di certi balli, era stato allestito un punto di
ristoro: qualche focaccia, cantuccini, vinsanto, aranciate e qualche bicchierino
di rosolio. Zelindo offrì ad Angelica un'aranciata, mentre lui si bevve un
bicchierotto di vino. Angelica, mentre sorbiva l'aranciata, ricevette una spinta
involontaria da una coppietta danzante, ed un sorso di aranciata andò a
macchiare di rosso la sua pettorina bianca. Se la prese per questo, ma Zelindo
cercò di confortare il suo disappunto, minimizzando l'accaduto. Arrivò la mezzanotte ed Angelica disse a Zelindo che sarebbe
dovuta rientrare, perchè i genitori non la avrebbero permesso di fare più tardi.
Lui le chiese dove si sarebbero potuti rivedere il giorno dopo, ma Angelica
disse che ciò non era possibile. Passarono alcune settimane ma Zelindo, nonostante che
praticasse frequentemente il territorio vicino alla casa che lei gli aveva
indicato, non ebbe a rivedere quella bellissima fanciulla, che evidentemente
aveva lasciato un segno nel suo cuore. Alla fine si fece coraggio: non poteva
finire tutto così. Il ricordo di quella serata così piacevole, il timore di non
rivedere più quella fanciulla che tanto l'aveva affascinato, lo spinsero una
mattina ad andare a bussare al portone di via delle Volpi numero 3. Bussò più volte e dopo qualche attesa avvertì il rumore di
passi malfermi che scendevano una scalinata. La porta si aprì e comparve
un'anziana donna vestita di nero, occhiali che a malapena le consentivano di
vedere. In cima alla scalinata era rimasto un vecchio, anch'esso malfermo e
ingobbito da fatiche lontane. Zelindo rimase incredulo, forse aveva
sbagliato portone, ma non era così, perchè tutti i particolari
dell'aspetto di quella fanciulla coincidevano con le descrizioni fatte
da entrambi: il colore dei capelli, quello degli occhi, la figura esile,
la voce flebile. La vecchia madre, dopo i comprensibili primi momenti
di sbigottimento, riacquistò il senso della realtà. Essa conservava
ancora vigore e determinazione, per cui dopo qualche minuto fu assalita
da un atroce dubbio: che Angelica fosse ancora viva ? L'indomani la vecchia andò dal sindaco del paese,
raccontando quel che era successo e fece di tutto per ottenere la
riesumazione della salma. La bara di Angelica venne riaperta, ma
Angelica era lì nel suo pallore di morte e nel suo aspetto di celeste
rassegnazione. Era ancora vestita con l'abito bianco con cui era stata
adagiata nella bara. Ma un particolare sconvolse i presenti a quel
triste rito, fra cui Zelindo. Una macchia rossa, fresca ed evidente, era
presente nella sua pettorina.

![]()

La
strada sale verso il paese, deserta e buia. Nessun rumore, nessun movimento,
nessuna presenza, tranne quell'ombra scura e ostinata
che aspetta seduta sul muricciolo di Bellaria, lungo la via. E, quando il
carretto si avvicina, essa si rimette in cammino, pochi passi davanti,
silenziosa.
![]()
Il giovane chiese di Angelica, raccontando come
l'avesse conosciuta qualche settimana prima, a carnevale. A questa
richiesta la donna trasalì: "E' la mia figliola, ma è morta due anni fa
! ".

![]()